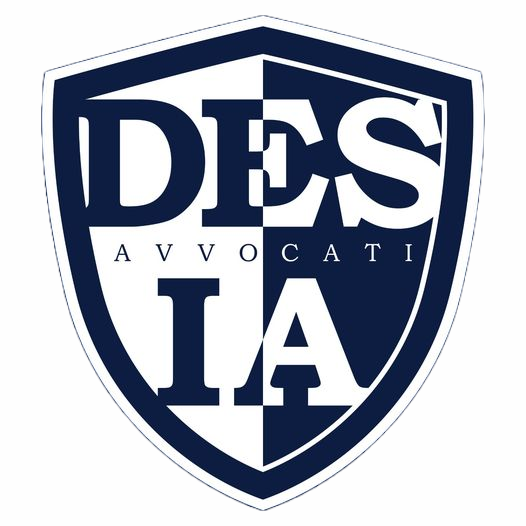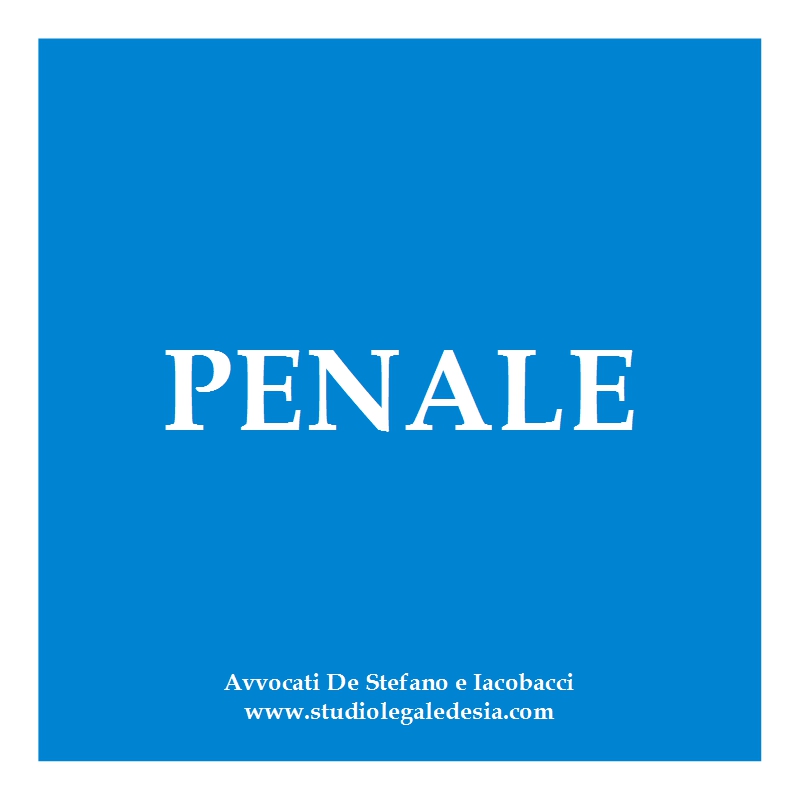Quando è possibile fare ricorso alla CEDU e cosa può fare la CEDU quando accerta la violazione dei diritti umani?
di De Stefano & Iacobacci Avvocati
Quando è possibile fare ricorso alla CEDU?
È possibile fare ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU) quando si ritiene di aver subito una violazione di uno dei diritti umani previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU) e dai suoi protocolli aggiuntivi.
I diritti umani protetti dalla CEDU includono il diritto alla vita, all’integrità personale, alla libertà e alla sicurezza, al rispetto della vita privata e familiare, al processo equo, alla libertà di espressione, alla libertà di religione, all’istruzione e alla libertà di riunione.
Per poter presentare ricorso alla CEDU, è necessario che il ricorrente abbia esaurito tutte le vie di ricorso interne, ovvero che abbia presentato ricorso a tutte le corti nazionali competenti e che queste abbiano rigettato il suo ricorso.
Inoltre, il ricorso deve essere presentato entro quattro mesi dalla data della sentenza definitiva a livello nazionale.
Se il ricorso è ritenuto ammissibile dalla Corte, questa procederà all’esame del caso e potrà decidere di dichiarare una violazione della CEDU. In tal caso, la Corte può condannare lo Stato convenuto a pagare un’indennizzo al ricorrente.
In Italia, il ricorso alla CEDU può essere presentato personalmente dal ricorrente o da un suo avvocato. Il formulario di ricorso è disponibile sul sito web della Corte.
È importante ricordare che la CEDU non è un’autorità giudiziaria ordinaria, ma un organo giurisdizionale internazionale che ha il compito di garantire il rispetto dei diritti umani da parte degli Stati contraenti la Convenzione.