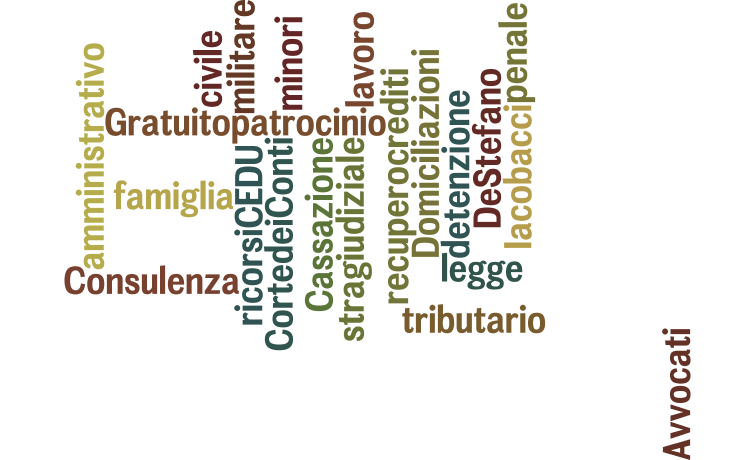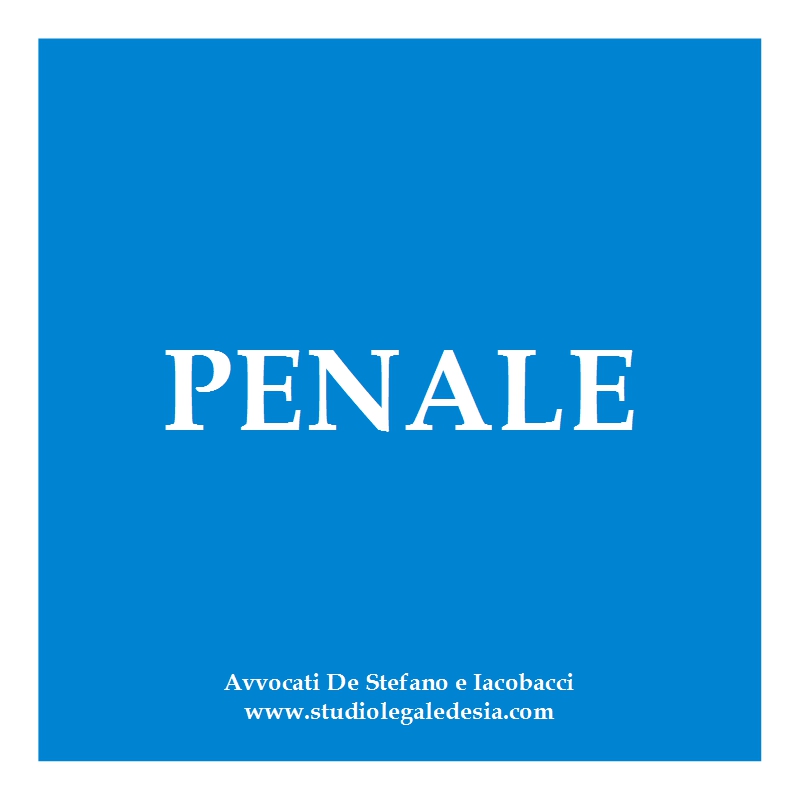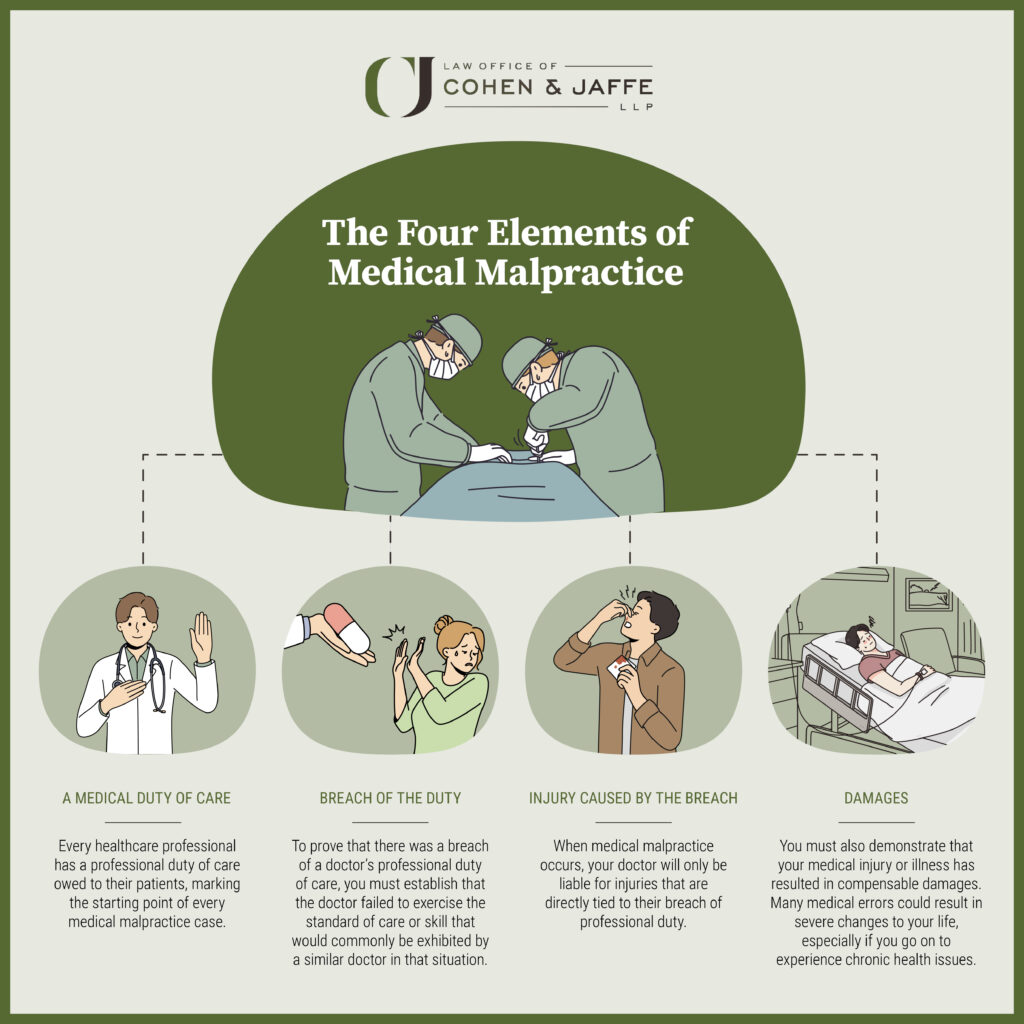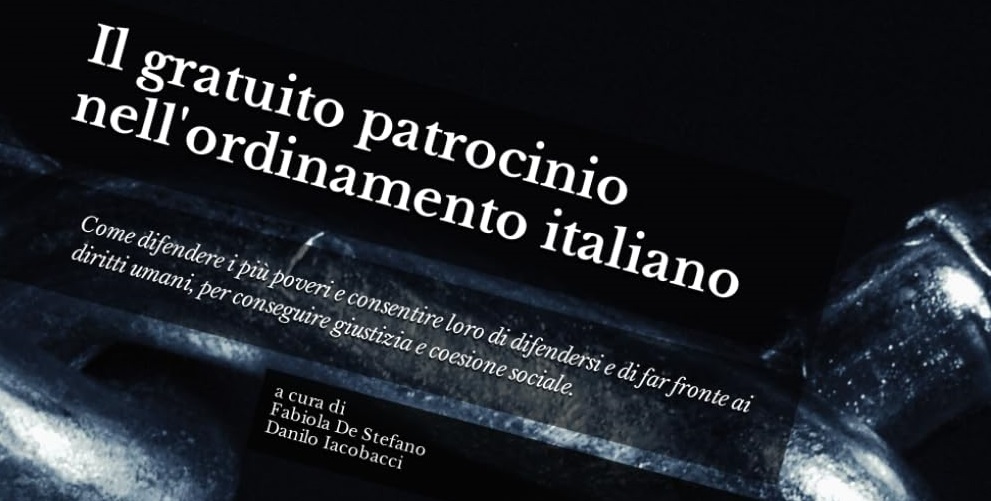La Corte costituzionale “libera” la particolare tenuità del fatto per la resistenza a pubblico ufficiale (sent. n. 172/2025)
1. Di che cosa si occupa la sentenza 172/2025
Con la sentenza n. 172 del 2025, la Corte costituzionale ha affrontato la disciplina della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione ai reati di:
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.),
- resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.),
quando il fatto è commesso contro ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell’esercizio delle funzioni.
Finora, l’art. 131-bis, comma 3, c.p. escludeva in modo assoluto l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in questi casi.
Il Tribunale di Firenze, investito di un processo per resistenza/violenza a pubblico ufficiale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 3 Cost., ritenendo irragionevole questa esclusione, specie dopo le modifiche apportate alla disciplina dall’ultima riforma Cartabia e dal d.lgs. 150/2022.
2. Il caso concreto: un gesto minimo, una risposta massima
Il giudice a quo era chiamato a giudicare una donna, incensurata, di corporatura minuta e affetta da patologia oncologica, imputata – in origine – per resistenza aggravata a pubblico ufficiale (artt. 337 e 339 c.p.).
Secondo l’accusa, durante una manifestazione politica del 2019, alla quale non veniva fatta accedere per ragioni di capienza, l’imputata avrebbe:
- toccato più volte con un dito il torace di un agente,
- e infine dato uno schiaffo al volto al medesimo agente,
per opporsi all’atto d’ufficio (il diniego di accesso alla manifestazione).
Il Tribunale ha riqualificato il fatto come violenza a pubblico ufficiale ex art. 336, primo comma, c.p. e ha ritenuto che, in concreto, la condotta potesse essere di particolare tenuità: gesto episodico, forza modesta, assenza di reale pericolosità sociale, movente legato al desiderio di partecipare alla manifestazione e non di turbarla.
Tuttavia, l’art. 131-bis, comma 3, vietava al giudice di applicare la causa di non punibilità, proprio perché il fatto riguardava gli artt. 336 e 337 c.p. commessi in danno di agenti di pubblica sicurezza/polizia giudiziaria in servizio.
Da qui il dubbio: è ragionevole che la legge impedisca sempre e comunque la valutazione della tenuità nei reati di resistenza/violenza a p.u. contro agenti in servizio, anche quando il fatto è minimo?
3. Il cuore della questione: l’art. 3 Cost. e il confronto con altri reati
Il Tribunale di Firenze ha impostato la questione sul terreno dell’art. 3 Cost. (ragionevolezza/eguaglianza), mettendo a confronto il regime di 336–337 c.p. con altri reati analoghi o più gravi, per i quali invece la particolare tenuità può operare.
Tra i tertia comparationis indicati:
- la violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo o giudiziario (art. 338 c.p.);
- la resistenza alla forza armata (art. 143 c.p.m.p.);
- la violenza o minaccia in danno di personale scolastico e sanitario (con le aggravanti specifiche introdotte negli anni).
La situazione paradossale, dopo le riforme, è questa:
- il reato di art. 338 c.p., più grave sul piano edittale (reclusione da 1 a 7 anni), è oggi ammissibile alla particolare tenuità, perché rientra nei limiti del nuovo art. 131-bis (minimo edittale non superiore a due anni e nessuna esclusione nominativa);
- i reati di artt. 336 e 337 c.p., meno gravi (reclusione da 6 mesi a 5 anni), restano invece esclusi ex lege dalla tenuità del fatto, se commessi contro agenti di p.s. o p.g. in servizio.
In altre parole, la particolare tenuità può operare per il reato più grave (art. 338), ma non per quello meno grave (336–337): esattamente il contrario di ciò che sarebbe logico in una prospettiva di proporzionalità e coerenza del sistema sanzionatorio.
4. L’evoluzione dell’art. 131-bis e il “corto circuito” normativo
La Corte ricostruisce l’evoluzione dell’art. 131-bis c.p.:
- Testo originario (2015)
- limite basato sul massimo edittale (non superiore a 5 anni);
- nessuna “eccezione nominativa” per singoli reati, ma solo esclusioni fondate su elementi oggettivi (crudeltà, motivi abietti, morte o lesioni gravissime, ecc.).
- Decreto sicurezza 2019 e modifiche 2020
- introduzione delle eccezioni nominative per alcune fattispecie, tra cui gli artt. 336 e 337 c.p., inizialmente in relazione a qualunque pubblico ufficiale, poi specificamente agli ufficiali/agenti di p.s. o p.g. in servizio.
- Riforma Cartabia (d.lgs. 150/2022)
- mutamento del criterio: non più massimo, ma minimo edittale (non superiore a 2 anni);
- ampliamento dell’area dei reati potenzialmente coperti dall’istituto;
- contestuale introduzione di ulteriori eccezioni nominative, tra cui la conservazione del divieto per artt. 336 e 337 c.p. quando la condotta è rivolta contro agenti di p.s./p.g. in servizio.
Risultato: art. 338 c.p. entra nel campo di applicazione della tenuità (minimo 1 anno, nessuna esclusione), mentre 336–337 ne restano fuori, se riferiti a forze dell’ordine.
La Corte prende atto anche della sopravvenuta aggravante del 2025 (d.l. 48/2025, conv. in l. 80/2025), che aumenta la pena fino alla metà per la violenza/minaccia contro agenti di p.s./p.g., ma evidenzia che il minimo edittale resta comunque inferiore a quello di art. 338 c.p.
Quindi, anche con l’aggravante, il quadro rimane irragionevole: il reato meno grave continua a subire un regime più severo quanto alla possibilità di riconoscere la particolare tenuità del fatto.
5. La motivazione della Corte: manifesta irragionevolezza e violazione dell’art. 3 Cost.
Nel “Considerato in diritto”, la Corte afferma espressamente che la questione è fondata.
I passaggi chiave:
- Omogeneità delle fattispecie:
- gli artt. 336, 337 e 338 c.p. tutelano tutti un bene giuridico complesso, che comprende il regolare funzionamento della Pubblica Amministrazione e la libertà/sicurezza della persona che esercita la funzione pubblica;
- la differenza è che l’art. 338 colpisce condotte di violenza o minaccia nei confronti di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, quindi in un contesto, se possibile, più grave, anche per le funzioni costituzionali coinvolte.
- Paradosso sanzionatorio:
è «manifestamente irragionevole» che la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sia ammessa per il reato più grave (art. 338 c.p.) e esclusa per i reati meno gravi (artt. 336 e 337 c.p.) commessi contro agenti di p.s. o p.g. in servizio.
- Continuità con la sentenza n. 30/2021, ma mutato contesto:
la Corte non smentisce la precedente sentenza n. 30/2021 (che aveva ritenuto legittima l’esclusione della tenuità per la resistenza), ma osserva che il quadro normativo è cambiato con la riforma del 2022 e con l’inclusione di art. 338 nel perimetro dell’art. 131-bis. Ne deriva una nuova distonia, non più sostenibile.
Questo squilibrio finisce per incidere anche sulla funzione rieducativa della pena: un sistema sanzionatorio internamente incoerente, in cui il meno grave è trattato peggio del più grave, è difficilmente compatibile con un assetto razionale e proporzionato di pene e cause di non punibilità.
6. Il dispositivo: che cosa viene dichiarato incostituzionale
Nel dispositivo, la Corte stabilisce:
«dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 131-bis, terzo comma, del codice penale,
nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 dello stesso codice».
Questo significa, in termini pratici:
- l’art. 131-bis, comma 3, non potrà più escludere automaticamente la particolare tenuità del fatto nei procedimenti per:
- violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.),
- resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.),
anche quando la persona offesa sia un agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria in servizio;
- il giudice torna ad avere la possibilità di valutare caso per caso, applicando la particolare tenuità ove ne ricorrano i presupposti generali (offesa di particolare tenuità, modalità della condotta, grado di colpevolezza, personalità dell’imputato, occasionalità del fatto, ecc.).
La Corte dichiara poi assorbita l’ulteriore questione subordinata sull’art. 339 c.p. (aggravante per il fatto commesso nel corso di manifestazioni pubbliche), proprio perché la pronuncia sull’art. 131-bis è già sufficiente a incidere sul caso concreto
7. Cosa cambia in concreto dopo la sentenza 172/2025
7.1. Per i procedimenti in corso
Nei procedimenti pendenti per:
- art. 336 c.p. (violenza/minaccia a p.u.),
- art. 337 c.p. (resistenza a p.u.),
commessi anche contro agenti di p.s./p.g. in servizio, sarà ora possibile:
- domandare l’applicazione dell’art. 131-bis c.p.,
- argomentando su tenuità dell’offesa, occasionalità della condotta, assenza di abitualità, circostanze soggettive dell’imputato, eventuale esiguità della violenza o della minaccia.
Non si tratta, ovviamente, di una depenalizzazione:
il reato rimane, ma il giudice può dichiarare non punibile l’imputato per particolare tenuità del fatto, laddove ricorrano tutti i presupposti.
7.2. Per i procedimenti definiti
Come per tutte le pronunce di illegittimità costituzionale in malam legem, la decisione della Corte si applica anche:
- ai procedimenti non ancora definiti con sentenza irrevocabile,
- e si riflette sui giudizi passati in giudicato solo attraverso gli strumenti propri dell’esecuzione penale (ad es. incidente di esecuzione, revoca della sentenza se la non punibilità per particolare tenuità del fatto risulta applicabile come lex mitior).
In pratica, la difesa potrà valutare:
- se chiedere la rideterminazione dell’esito processuale in corso di esecuzione,
- oppure se sfruttare la nuova apertura solo nei processi ancora pendenti.
8. Una svolta importante nel rapporto tra ordine pubblico e proporzionalità della risposta penale
La sentenza n. 172/2025 non “smonta” la tutela del pubblico ufficiale e delle forze dell’ordine:
la Corte ribadisce che si tratta comunque di reati plurioffensivi, che proteggono sia la persona fisica del funzionario/agente, sia il buon andamento e l’autorevolezza della Pubblica Amministrazione.
Ciò che cambia è un’altra cosa:
- si abbandona la logica del divieto automatico di tenuità;
- si restituisce al giudice il potere di distinguere tra:
- episodi di reale aggressione all’ordine pubblico,
- e condotte minime, episodiche, simboliche, spesso legate a contesti di tensione (come le manifestazioni pubbliche), in cui la risposta penale piena può risultare sproporzionata.
In definitiva, la Corte riequilibra il sistema:
protezione delle forze dell’ordine sì, ma non al prezzo di trattare il reato meno grave peggio di quello più grave, né di impedire al giudice di riconoscere quei casi in cui il diritto penale, davvero, può e deve arretrare.